100 anni fa nacque Friedrich Dürrenmatt in un piccolo centro dell’Emmental svizzero. Lo scrittore a cui rise la fortuna della notorietà e del benessere economico piuttosto tardi, non volle mai aprirsi troppo al mondo. Viaggi all’estero si possono contare sulle dita di una mano e la stessa residenza prescelta dal Nostro sul Lago di Neuchatel dista giusto 70 km dal suo luogo di nascita. Pero egli divenne suo malgrado un uomo di mondo, un mondo visto in certa maniera e descritto attraverso le sue storie dal gusto nero e spesso macabro. Dürrenmatt, l’anticonformista in una Svizzera conformista, scrisse parabole dall’ampio respiro rimanendo con ironica contraddizione piantato nel suo cantone Berna: “non sono uno scrittore da campagna, ma la campagna mi ha partorito e di conseguenza sono ancora un villano con la lingua lenta.”

Contra-dire era la sua cifra anche nell'altra sua pulsione creativa, la pittura. Essa, da principale occupazione degli inizi, restò la passione di tutta la vita ed accompagnò la sua attività di scrittore e drammaturgo. In molte opere, specie nelle caricature e nei ritratti, è presente lo stesso humour nero e la stessa tagliente critica alle ipocrisie della società delle opere letterarie.
Per quanto prediligesse una posata ed ironica contemplazione del mondo consumando nel fra tempo il Bordeaux come una Ferrari consuma benzina, Dürrenmatt non evitò il conflitto con l’ambiente circostante. Durante una delle sue ultime apparizioni, la orazione in favore di Vaclav Havel, non riuscì ad esimersi da un commento critico, che malgrado il tono gentile divenne una resa di conti assurdo-umoristica con la sua patria.
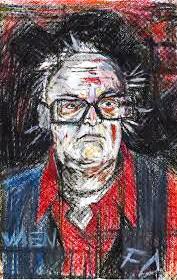
“Lo svizzero”, commentò Dürrenmatt riferendosi al periodo di carcere di Havel sotto il regime comunista, “gode del vantaggio dialettico di essere al contempo prigioniero e secondino. ... La Svizzera, una prigione: il carcere non ha bisogno di mura, poiché i suoi carcerati sono guardie che sorvegliano sè stessi; i secondini sono persone libere e perciò fanno affari tra di loro e con il resto del mondo, e quanti! Essendo pur tuttavia prigionieri non possono aderire alle Nazioni Unite e l’Unione Europea procura loro un forte mal di testa.” L’orazione si tenne nel novembre del 1990, tre settimane prima della morte dell’autore. „Non raccontare fesserie e non aggiungere mistero a mistero“, suonò il conclusivo consiglio dato a sé stesso.
A volte gli bastava dare un nome inequivocabile.
__________________________________________________________________________________________________________________
Le sue storie
La letteratura dovrebbe – così il suo tardo credo – “diventare di nuovo così leggera, che non segni più nulla sulla bilancia della critica letteraria. Soltanto così riuscirebbe a recuperare peso.” E detto fatto Dürrenmatt alla ricerca di storie particolari, assurde, macabre per innalzarle alla fine a parabole umane universali. Si racconta che il nostro uomo di Konolfingen abbia conquistato la moglie con una storiella su un procedimento giudiziario che vedeva lo stesso giudice divorare il corpo del reato, vale a dire, una salsiccia di carne umana.
Il giudice e il suo boia (1952), uno tra i primi testi del “giallo di campagna”, inizia con il tentativo del poliziotto Tschanz di trovare la strada per Lamboing, un centro rurale vicino a Neuchâtel, domicilio dello stesso scrittore. E l’autore dalla sua camera di lavoro gli dà gentilmente una mano con il consiglio: „In ogni caso non lasciarsi osservare, altrimenti finiamo ancora in un libro”. Il che accade inevitabilmente. Il testo continua piuttosto stranamente, strano anche il protagonista, il commissario Bärlach che indaga prevalentemente contro sè stesso.
Si tratta di un romanzo giallo che esprime pur tuttavia una profonda critica nei confronti del racconto poliziesco con le sue consuete procedure criminalistiche. Piste ed indagini risultano sin dall’inizio sbagliate, il commissario Bärlach conosce ben presto il colpevole ma prosegue comunque le indagini per costruirsi lui stesso una Giustizia non ottenibile con i consueti metodi investigativi. Questa Giustizia non conosce pietà.
Il commissario, un solitario disilluso ricompare poi nel romanzo Il sospetto. Anche in questo caso il poliziotto riesce pur sbagliando l’investigazione ad individuare il colpevole; come già precedentemente egli non si limita all’arresto e alla condanna giudiziaria dell’omicida - le evidenze dell’indagine giudiziaria non scalfiscono d’altronde minimamente immagine e reputazione di un onesto e coscienzioso scienziato, dietro al quale si nasconde la figura di un criminale nazista impenitente. Così Bärlach si fa nuovamente promotore arbitrario di un atto di giustizia fuori legge dove il fato consegna le armi al caso.
Anche ne Il sospetto, come successivamente ne La promessa, ricorre il motivo del “crimine rimasto irrisolto, nascosto”. Gli atti risultano essere indubitabilmente criminosi, ma la giustizia non riesce a scoprire le prove del reato perché il presente risulta essere impenetrabile. Il romanzo ripropone, come già ne Il giudice e il suo boia, con la figura del ex-medico di un lager nazista il problema della posizione della Svizzera nei confronti dei crimini nazisti e, in secondo piano, la domanda su come sia possibile stroncare il male in un mondo privo di un’istanza metafisica capace di incutere il giusto timore morale.
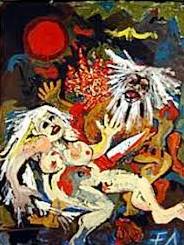
Anche nel racconto La promessa, l’attenzione della novella è posta non più sul crimine, ma sull’investigatore. Un caso delittuoso diviene spunto per l’investigazione sul detective. Il sottotitolo suona significativamente “requiem per il romanzo giallo”. L’umanamente impegnato commissario Matthäi naufraga alla fine con la sua indagine su un serial killer di bambine per colpa del puro caso. Il nome dato dai suoi colleghi e dallo stesso autore “Matthäi l’ultimo” (Matthäi l’ultimo) è un’allusione a Matteo l’apostolo che chiamato soltanto dopo il tradimento di Giuda fu l’ultimo dei dodici. Il commissario è anch’esso “l’ultimo”, è “alla fine” delle sue indagini e della sua carriera, così come il romanzo giallo è alla fine della sua parabola letteraria.
Dürrenmatt pone all'inizio del racconto La panne la domanda retorica se vi siano ancora storie possibili, storie per scrittori. Data l’indecifrabilità di un mondo pieno di imprevisti, di panne appunto, conclude rassicurato che fin quando vi saranno, malgrado il progresso tecnologico, queste panne, si avranno anche possibili storie da raccontare. Con questa soddisfatta convinzione si volge al racconto vivo che inizia appunto con la panne automobilistica del rappresentante tessile Alfredo Traps e volge infine all’innevitabile esito tragico.
La panne, mirabile esempio di un rovesciamento di situazione del protagonista nei confronti del concetto di giustizia, è la parabola della colpevolezza del singolo. “Bisogna confessare, volente o nolente; c’è sempre qualcosa da confessare”, giudicano le eminenze grigie durante quel strano gioco di ruoli ambientato in quell’ancora più strano albergo svizzero. Questa è la massima che Dürrenmatt lascia al lettore: il mondo stesso è un unico crimine che non può essere né svelato né espiato.

I suoi drammi
Il suo capolavoro assoluto, quello che salvò lui e sua famiglia dalla persistente miseria economica, è: La visita della vecchia signora (1956), la grande parabola sugli abissi dell’essere umano, una pièce teatrale sulla corruzione degli uomini e, di nuovo, la colpevolezza del singolo. La vecchia signora che visita la città di Güllen (Gülle = letame) è appunto la corruzione, la tentazione della cupidigia umana. Il dramma portava significativamente il sottotitolo “commedia del boom economico”. La reazione dei cittadini di Güllen alla proposta della “vecchia signora” di benessere per tutti a certe condizioni è la prova che l’uomo sa abituarsi perfettamente al disumano anche dopo averlo svelato come tale. I ricorrenti temi di “destino e giudizio” “colpa ed espiazione” “vendetta e sacrificio” ricordano quelli dell’antica tragedia, se non vi fossero i mezzi stilistici tipici della farsa/grottesca a costruire in questo modo una personalissima concezione del teatro caratterizzata da trame macabre e soprattutto grottesche.
Ciò accade anche ne I fisici , una parabola sulla minaccia dell’umanità da parte della “civilizzazione” al tempo della bomba nucleare. Luogo dei delitti è un padiglione di una linda clinica psichiatrica abitato soltanto da tre pazienti: i fisici Newton, Einstein e Möbius. Ad portarli insieme è un segreto dalle terribili conseguenze per la sopravvivenza dell’umanità e soltanto il confinamento nel manicomio sembra poter garantire l’incolumità sia loro, sia del mondo. Anche qui è il caso a far partorire la storia e a farla volgere verso la peggiore svolta possibile.
Dürrenmatt vuole, simile a Bertolt Brecht creare distanza tra lo spettatore e l’accadimento sul palcoscenico. Il mezzo stilistico più utilizzato a tal proposito è lo straniamento attraverso cui l’autore mette in discussione ciò che è generalmente accettato svelandone le contraddizioni. Elementi tragico-grottesche tentano una sintesi di ciò che è inconciliabile. Il dramma classico non funziona più; esso presuppose un mondo “visibile, decifrabile”. Lo stato attuale invece “è sempre anonimo, impenetrabile e burocratico. I rappresentanti reali mancano e gli eroi tragici non hanno nomi.”
Il teatro di Dürrenmatt è sempre parodia. Esso cita una forma di dramma per dimostrarne subito l’anacronismo, i suoi eroi finiscono impietosamente smontati. La tragicommedia è a suo dire l’unica forma drammatica capace di esprimere oggi il tragico.
Per Dürrenmatt i fatti non conducono esattamente alla verità ma confondono, forse nascondono la verità, non la svelano mai completamente ma solo alcune parti, quelle più semplici e consolatorie. E la giustizia è una cosa troppo sopravvalutata dalle persone. Nella imperscrutibilità del mondo moderno la colpa viene cancellata, rimossa. E mancando allo svizzero, a differenza di Brecht, qualsiasi Weltanschauung (ideologia) moralizzante, resta una sola soluzione:
Soltanto la farsa può venire a capo della modernità.
Fonte: Wikipedia
